...ma qualcuno aveva già previsto tutto:
Elogio del marmo di Adriano Scianca -
Di che è fatta l’italianità?
- L’italianità è marmo che vince la palude .
Era chiamato così, ai tempi della Rivoluzione francese, il centro del nuovo assetto politico post-rivoluzionario. Ovvero il segmento degli opportunisti, degli ignavi, dei vili, degli indecisi. La palude è, in effetti, il luogo in cui non è possibile la decisione. Sulla palude non si può edificare, nessun eroe fondatore può tracciare il solco primigenio e dare origine ad una nuova civiltà. Nella palude si affonda, perché è il luogo dell’informe, della mancanza di solidità, è ristagnare venefico di acquitrini melmosi che non hanno la durezza e la fecondità della terra né l’inquietante e grandiosa profondità del mare. La palude può però essere vinta dal lavoro e dalla volontà umana che, annientandola, edificano un mondo propriamente umano. Può essere redenta allorché lascia il posto al marmo. L’enorme, enigmatico monolito nero che fa la sua comparsa nel bellissimo incipit di 2001: A space odyssey mette bene in evidenza questo carattere “puramente umano”. Il monolito, squadrato, geometrico, ieratico si distingue immediatamente da tutto ciò che si trova intorno ad esso, dal paesaggio pietroso e desertico, ma anche dalle stesse scimmie, ancora semplicemente e totalmente immerse nella natura. Il monolito è opera umana e forse proprio in virtù di questa sua non-naturalità esso è in grado di trasformare per sempre l’esperienza del mondo propria delle scimmie, che da quel momento scoprono lo strumento-arma e tutto ciò che ne consegue: la tecnica, la caccia, il dominio, la potenza. «Il tempio, in quanto opera, dispone e raccoglie intorno a sé l’unità di quelle vie e di quei rapporti in cui nascita e morte, infelicità e fortuna, vittoria e sconfitta, sopravvivenza e rovina delineano la forma e il corso dell’essere umano nel suo destino […]. Eretto, l’edificio riposa sul suo basamento di roccia […]. Stando lì, l’opera tiene testa alla bufera che la investe, rivelandone la potenza. Lo splendore e la luminosità della pietra, che essa sembra ricevere in dono dal sole, fanno apparire la luce del giorno, l’immensità del cielo, l’oscurità della notte». Componendo questa evocativa descrizione, Martin Heidegger ci catapulta nel cuore di una civiltà, quella ellenica, che della luminosità e della durezza fece la sua ragion d’essere. Lo stesso termine “marmo”, del resto, deriva dal greco marmaros, con il significato di “pietra splendente”. La Grecia antica era in effetti ricca di cave di marmo, con numerose varietà pregiate di marmi bianchi (pentelico, tasio, nassio, pario). In quella terra, nel momento aurorale della civiltà europea, il marmo è lo sfondo a partire da cui si stagliano gli ierogrammi che danno corpo ad un linguaggio che dice di bellezza, disciplina, sapienza e gioventù. Un linguaggio che riecheggerà, e non con intenzioni innocenti, in pieno Novecento nella luminosa evocazione del Dorische Welt compiuta da Gottfried Benn . Quando dall’Ellade l’uso del marmo si trasferisce a Roma, esso va ad alimentare una cultura “monumentale”. “Monumento” deriva dal latino monère, “ricordare”. Cultura monumentale è quindi l’anelito tragico e grandioso di una civiltà che osa sfidare l’eternità, autocomprendendosi in un sogno imperiale di sovrumana grandezza. Questo sforzo grandioso, inconcepibile in ogni orizzonte piccolo-individualista, narcisista, umanistico e “democratico”, non è altro che l’estensione al livello dell’impresa collettiva di quell’etica dell’onore che prescriva come sommo bene la “gloria-che-non-muore”. È per questo che si fondano le città, si tracciano i solchi e si creano le civiltà: non per un borghese e burocratico “contratto sociale”, ma per darsi un destino. O, come dice la Bibbia quando lancia le sue invettive contro l’avventura storica dell’uomo: per farsi un nome. Ma l’impresa imperiale non può che essere un’avventura collettiva. Roma, quindi, è sempre e comunque res publica. «Repubblica / la cosa di tutti / fa pensare a marmo e acquedotti / a città romane / costruite da gente inventiva e capace / di ispirazione / una cosa da tutti», canta SFS. E non è forse un caso che quando la regista statunitense Julie Taymor vorrà ambientare, al di là di ogni tentazione di mimetismo realista, il Titus Andronicus di Shakespeare, non troverà altra ambientazione possibile che nell’architettura realmente “tragica”, perché ispirata a tragica grandezza, dell’Eur romano. Ne uscirà fuori quel gioiello incompreso che è Titus. L’Eur, in effetti, non è altro che la pietrificazione di un’idea. Il 21 aprile 1922, pochi mesi prima della presa della capitale, Mussolini dichiarava: «La Roma che noi onoriamo non è soltanto la Roma dei monumenti e dei ruderi, la Roma delle gloriose rovine […] ma soprattutto, la Roma che noi vagheggiamo e prepariamo è un’altra: non si tratta di pietre insigni ma di anime vive, non è contemplazione nostalgica del passato, ma dura preparazione dell’avvenire». Concetti analoghi venivano espressi dall’architetto fascista Enrico Del Debbio: «Vorremo noi creare con forme nostre e sincere allo scopo, al tempo, al materiale, la Roma moderna […]. L’arte non è copia cristallizzata ma nuova creazione». L’immagine del mondo neo-romana scolpita nell’Eur, colpisce in effetti l’osservatore, soprattutto in confronto all’assenza di immagine dell’architettura “democratica”. Fanno riflettere, a tal proposito le osservazioni che Ugo Ojetti, giornalista e critico d’arte, annota nel suo diario dopo aver ascoltato dalla bocca del Duce i futuri progetti del fascismo per Roma: «Tra cinque, tra dieci, tra quindici anni […]. I ministri di una volta non potevano dire nemmeno tra un mese», scrive. C’è, in quei marmi bianchi squadrati, in quello forme “doriche”, un progettualità epocale sconosciuta alla posterità antifascista. Come osserva lo storico Emilio Gentile: «Il fascismo ebbe il culto della monumentalità come espressione collettiva di una civiltà che vuole lasciare la sua impronta nella storia sfidando il tempo, conferendole per questo un significato simbolico e sacrale». Cosa che comporterà la massima costernazione dello storico dell’arte francese Louis Gillet che, in visita alla Mostra della Rivoluzione, esclamerà, non senza una certa nostalgia per il paese della pizza e del mandolino: «E’ questa ancora Italia? E’ questa la terra dei sorrisi, del sole e della bellezza?». È la vecchia nostalgia per l’Italia serva ma simpatica, per il chiaro di luna e la torre di Pisa, con «gente in costume da bagno e occhiali di plastica, gente che si abboffa di pasta ma poi fa ginnastica, che vuole bene alla mamma e quando segna la nazionale va in crisi mistica», come canta ancora SFS. Ma ha ragione Gillet. Quella cui lui aveva avuto la fortuna di assistere era un’altra Italia e un’altra Roma. Era la Roma nuova così descritta dal senatore Vittorio Cini: «Chi venendo da Roma o dal mare si affaccerà dalla via dell’Impero […] vedrà aprirsi, fra candidi marmi e travertini dorati, la città nuova, viva d’acque e di verde; una città degna di stare accanto all’antica, ma con questo i più: che essa, nella sua cornice di severa e potente architettura, sarà atta ad accogliere la multianime, dinamica vita d’oggi e di domani». Come marmo che vince la palude.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

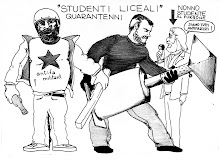
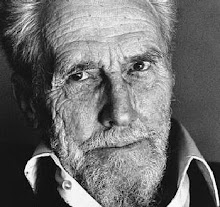




















Nessun commento:
Posta un commento